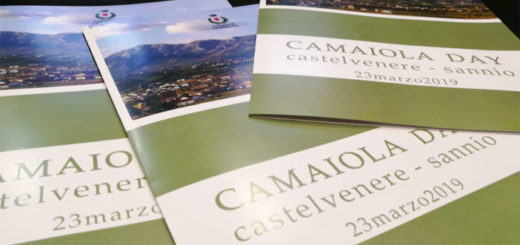Altre due terre abitate esistevano nel tenimento “vastissimo” che è ora di San Giorgio la Molara: S. Andrea e Pietramaggiore

Le iscrizioni più antiche, che pure ci sono e parecchie, sono tutte sepolcrali e private rinvenute in prossimità del Tammaro (principalmente nei fondi Fragnito), riportate senza alcun commento da Mommsen in (Inscriptiones regni neapolitani latinae) e Guarrucci in (Monumenta Ligurum Baebianorum),da queste si capisce che gli antichi dovevano stare in basso, in località più prossima al fiume nella valle di Calise (*Sanctam Mariam in Calisi). Successivamente con le invasioni barbariche e le devastazioni gotiche e saraceniche, si cominciarono ad edificare i borghi, a guisa di nidi di rondine, sui siti più inaccessibili e facili alla difesa.
San Giorgio La Molara (**Sancti Giorgii de la Molinaria): divenne, per la sua posizione strategica, il più grande dei paesi nei dintorni, fino a raggiungere 5878 abitanti nel 1790, cifra non mai più superata, anzi diminuita, nelle epoche anche successive.
E’ a partire dall’ XI secolo che si trovano maggiori informazioni delle antiche “terre abitate” dell’attuale territorio di San Giorgio La Molara: S. Andrea e Pietramaggiore (nelle più antiche carte conosciute col nome di S. Andreae de Molinara e Preta Maiori.
S. Andrea esisteva nell’epoca normanna, e faceva parte della Contea di Ariano. Passò poi alla baronia di Montefusco. Nella bolla di delimitazione del territorio beneventano (1350) è chiamato Castrum S. Andreae de Molinara. Poi decadde, e fu ridotto alle proporzioni di un semplice casale, che rimaneva sulla parte sinistra del Tammaro. Esisteva ancora al 4 agosto 1585, quando Antonio Carafa vendè a Giampaolo Cossa, duca di S. Agata, la terra di S. Giorgio la Molara ed i feudi di S. Andrea e Pietramaggiore con le loro “ville seu casali et signanter palazzo della Corte terraggi di S. Andrea e Pietramaggiore, lo campo delli monaci, Mazzocca”. Dai cedolari di Principato Ultra risulta che nel 1549 fu tassato per S. Andrea uno Scipione Carafa. È ignoto quando scomparve questo casale dal novero dei luoghi abitati.
Pietramaggiore ebbe maggiore importanza; stava anche sulla sinistra sponda del Tammaro tra l’attuale S. Giorgio e Paduli, e veniva chiamata Preta muiure, per distinguerla da Preta pucina situata dirimpetto, sulla opposta sponda dello stesso fiume (evidentemente l’attuale Pietrelcina). Dipendeva dal Conte di Ariano. Nel 1137 fu presa dal Duca Rainulfo, al quale si sottomise Roberto di Pietramaggiore, barone del conte di Ariano. Nel 1138, mentre Re Ruggiero si accampò al Ponte Valentino, il Duca Rainulfo era nelle vicinanze di Pietramaggiore: ” Dux autem nominatus Raynulphus, et erat prudentia animi, in finibus morabatur Praetemaioris, pertractans, ut castellum Apicis, quod Rex minabatus obsidere, virtute, et animo se illud liberaret “.
Il Re Ruggiero si portò sulla sponda destra del Tammaro, occupò tutte le relative contrade, diede a sacco ed a fuoco tutti i paesi e poi, prendendo alle spalle il nemico, occupò S. Giorgio e Pietramaggiore, verso la fine dello stesso anno 1138.
Sotto Guglielmo II (1173-1185) il feudo di Pietramaggiore era posseduto dalla Corte, che lo aveva tolto ad Ugo, figlio di Fulcerio, ed a Simone, figlio di Ruggiero e stava nella baronia di Montefusco. Ugo rimase in possesso di pochi villani e del feudo di S. Andrea.
Catalogo dei baroni: “N. 426. Curia tenet in demanium feudum duarum militum, quorum augmentum sunt milites IV, quod tenuit Hugo filius Fulceri, de Simon filius Rogerii in Petra Maiori “. N. 427. ” Hugo filius Fulceri dixit, quod tenet in Petra maiori villanos XV et cum augmento obtulít militem unum. Et in Sancto Andrea, etc.”.
Nell’ordinanza di Carlo I d’Angiò dell’8 luglio 1269 per la riedificazione e l’armamento del Castello di Crepacore trovasi requisita Pietramaggiore per il contingente di tre fantaccini armati ed otto operai: “rervientes 3 et alios homines cum zappis 8”.
Figura nuovamente il paese Pietramaggiore nella bolla del 1350, ed è chiamato Castrum Praetemaoris, tra S. Andrea e Paduli.
Della baronia di Montefusco appartenevano anche S. Andrea di Molinara, Paduli, Fornonovo, Monteleone, nella bolla del 1350 i diversi paesi vengono segnati l’uno appresso l’altro con esattissima geografica precisione e, quindi dopo S. Giorgio v’è S. Andrea, poi Pietramaggiore, quindi Paduli, col sobborgo o casale di S. Arcangelo, più appresso Montemale, Tenchiano, etc.. quindi Montefusco coi casali, e poi Tufo, etc.
Nel 1440 Pietramaggiore esisteva ed era di una certa entità perché poteva alloggiare gran numero di armati. Era l’epoca della guerra tra Alfonso d’Aragona e Renato d’Angiò per la successione del reame di Napoli.
Nel Diario di Monteleone, pag. 115; si legge che Renato lasciò Napoli entrò in Paduli il 1° febbraio 1440, che il Rosso Danese ed il Bozzo, quantunque nemici, lo complimentarono dei due cavalli e sei tazze di argento, e poi da Pietramaggiore vennero ad unirsi a lui con 300 fanti e mille lance per accompagnarlo a Lucera, “dove la compagnia del Re tutta per essere venuta sempre sopra la neve patì molte enfiature di gambe e di piedi”.
Pietramaggiore soffrì molto nel trremoto del 1456, fu distrutta e ridotta allo stato di casale. Così esisteva ancora nel 1585 sotto il dominio di casa Carrafa; dove passò ai Cosso di S. Agata, e poi ai Caracciolo di Torrecuso. Il 15 settembre 1639, in occasione del pagamento di un “relevio” per il feudo di Pietramaggiore, fu fatta una esatta descrizione della località, e fu detto che un miglio verso mezzogiorno dal principio del feudo si trovava un castello finito. Dal che è chiaro argomentare che nel 1639 già non esisteva più il casale, e v’era rimasto solo il castello, del quale tuttavia s’osservano pochi ruderi. Confinava col bosco di Mazzocca, con Ginestra, Buonalbergo e Terraloggia dirimpetto. Però Pietramaggiore faceva parte del territorio di S. Giorgio la Molara fin dal 1549, e forse da molto prima. Infatti nel rammentato “cedolario” del 1539 fu tassato Scipione Carafa per il feudo di Pietramaggiore con questa iscrizione: “informatio introitum feudi Petrae majoris siti in territorio S. Georgii Molinariae, quod possidetur per Scipionem Carafa de Napoli”.
La unione fu sotto casa Carafa ed il casale di Pietramaggiore divenne dipendenza della Università di S. Giorgio la Molara, rimanendo però soggetto per la parte spirituale al Vescovo di Ariano, che nominava l’Abate rurale di Pietramaggiore, titolo che è anche adesso una delle dignità famose del clero di Ariano.
* Nella bolla di Dicembre 1084, datata da Salerno e sottoscritta dal celebre Gregorio VII, si conferma a S. Sofia, tra gli altri fondi e chiese, Sanctam Mariam in Calisi. Qui poi non v’è alcun dubbio, S. Maria di calise apparteneva a S. Sofia, e facilmente fu la nuova denominazione data ad antico pago nell’epoca Cristiana. Così si chiamava la contrada dove esistono i sepolcreti.
** nel 1350, S. Giorgio fece parte del territorio beneventano, giusta la bolla di Clemente VI da Avignone; e fu chiamato Castrum Sancti Georgi Molinari.